XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) – Lectio divina
Sir 35,15-17.20-22 Sal 33 2Tm 4,6-8.16-18

O Dio, che sempre ascolti la preghiera dell’umile,
guarda a noi come al pubblicano pentito,
e fa’ che ci apriamo con fiducia alla tua misericordia,
che da peccatori ci rende giusti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del Siràcide Sir 35,15-17.20-22
La preghiera del povero attraversa le nubi.
Il Signore è giudice
e per lui non c’è preferenza di persone.
Non è parziale a danno del povero
e ascolta la preghiera dell’oppresso.
Non trascura la supplica dell’orfano,
né la vedova, quando si sfoga nel lamento.
Chi la soccorre è accolto con benevolenza,
la sua preghiera arriva fino alle nubi.
La preghiera del povero attraversa le nubi
né si quieta finché non sia arrivata;
non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto
e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Il grido del povero che tocca il cielo
Il libro del Siracide, scritto tra il 200 e il 180 a.C. da Gesù ben Sira a Gerusalemme, appartiene alla grande tradizione sapienziale d’Israele. È un’opera che intreccia osservazione della vita quotidiana, fede nella Legge e fiducia nella giustizia di Dio. Il contesto immediato del capitolo 35 (vv. 1-26) riguarda il culto: offerte, sacrifici, voti. Ma, in un movimento tipico della sapienza biblica, l’autore sposta l’asse dalla mera ritualità alla disposizione interiore. Non basta offrire doni a Dio; è necessario che il cuore sia retto. Così, dopo aver parlato del sacrificio gradito (vv. 1-14), il sapiente descrive ciò che più di ogni offerta commuove Dio: la preghiera del povero.
Nelle parole del Siracide si percepisce un’intensità drammatica: il povero non è semplicemente uno che manca di beni materiali, ma colui che non ha altra forza né difesa se non Dio. La povertà diventa così categoria teologica: è lo spazio in cui l’uomo riconosce il proprio limite e affida tutto a Dio. Nella spiritualità d’Israele, questa è la ‘anawàh, l’umiltà che apre il cuore alla misericordia divina.
Il sapiente contrappone il comportamento umano, spesso segnato da parzialità e ingiustizia, al giudizio di Dio che “non fa preferenze di persone”. Questa formula riprende una linea costante della Torah e dei Profeti (Dt 10,17; Is 11,4; Sap 6,7): Dio è imparziale, ma il suo orecchio è teso verso chi non ha voce. L’orfano e la vedova, i due volti emblematici della vulnerabilità sociale, sono figure che rappresentano tutti coloro che vivono nell’impotenza. L’Altissimo diventa per loro un giudice giusto e un difensore tenero. In un mondo in cui la giustizia umana è spesso cieca, il Siracide proclama che esiste un tribunale divino in cui la voce dell’oppresso non viene zittita. La preghiera del povero è descritta con immagini potenti: «attraversa le nubi», «non desiste finché l’Altissimo non intervenga». Il movimento è ascensionale, quasi cosmico. Essa è ostinata, non per arroganza ma per fiducia: il povero sa che Dio lo ascolta, e questa certezza lo sostiene. Il linguaggio richiama il salmo 34(33) («Questo povero grida e il Signore lo ascolta») e prepara il terreno per la spiritualità dei poveri del Signore (‘anawim YHWH), che diventeranno il grembo del Vangelo.
In questa prospettiva, il Siracide si avvicina già alla sensibilità profetica di Amos, Isaia e Michea: Dio non si lascia commuovere dal sacrificio di chi opprime, ma si lascia toccare dal gemito di chi spera contro ogni speranza. La preghiera del povero, dunque, è liturgia del cuore, non del tempio. È un sacrificio che nessun fuoco brucia ma che raggiunge il cielo come profumo gradito.
Il Siracide mostra che la vera sapienza nasce dalla giustizia e dall’umiltà. Il povero diventa maestro spirituale perché vive nella verità della propria condizione. Gesù stesso, nel Vangelo, si riconoscerà in questa linea profetica: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3). Il povero non è semplicemente un destinatario della pietà, ma il luogo teologico dove si rivela la compassione di Dio.
Il credente che prega impara che la preghiera autentica non nasce dal privilegio, ma dal bisogno; non dal merito, ma dalla fede. Il silenzio di Dio non è indifferenza, ma spazio di attesa. Il grido del povero attraversa le nubi: questo è il linguaggio dell’insistenza, della speranza che non si spegne.
Nella spiritualità d’Israele, la preghiera non cambia Dio, ma il cuore di chi prega. E tuttavia, il Dio biblico si lascia toccare: “Finché l’Altissimo non intervenga, renda giustizia ai giusti e ristabilisca l’equità” (v. 22). La fede del povero diventa così partecipazione al mistero stesso della misericordia divina: una forza umile che cambia il mondo dal basso.
In questa pagina si compendia tutta la teologia della speranza biblica: la preghiera del povero non è un sussurro che si perde nel vento, ma un filo di voce che raggiunge il cuore di Dio.
Salmo responsoriale Sal 33
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2Tm 4,6-8.16-18
Mi resta soltanto la corona di giustizia.
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone.
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani
Le parole attribuite a Paolo hanno il sapore del testamento spirituale. Il tono è commosso, ma non rassegnato: è una confessione di fede e un incoraggiamento alla perseveranza. In un contesto in cui la comunità è provata e Timoteo appare fragile e scoraggiato, Paolo offre la sua stessa vita come esempio di fedeltà e come modello di servizio pastorale Il verbo greco «spéndomai» indica il versare una libagione, un’offerta di vino o sangue versata accanto al sacrificio. Paolo interpreta la sua morte non come fallimento, ma come atto di culto, come compimento di un’esistenza totalmente donata. La sua vita è stata una liturgia vissuta: ogni fatica apostolica è stata un’offerta al Signore. Questa prospettiva trasforma la morte in un passaggio — analýseōs, “partenza” — come lo sciogliersi di una nave che salpa verso il porto di Dio. L’apostolo, presagendo l’avvicinarsi l’ora del martirio nel quale avrebbe offerto in sacrificio a Dio la sua esistenza, sintetizza la sua vita missionaria con le immagini della battaglia e della corsa. Esse indicano la consapevolezza di Paolo di aver faticato per annunciare il Vangelo, ora scontrandosi con i nemici della Croce, ora gareggiando nell’amore con coloro che il Signore ha messo sulla sua strada per essere testimone di Lui fino ai confini della terra. La metafora militare (agon), sportiva e cultuale si fondono in una sintesi sapienziale. L’“agon” non è solo un conflitto esterno, ma la lotta interiore per rimanere fedele al Vangelo in mezzo alle prove, alle persecuzioni e alle delusioni. La “corsa” evoca l’impegno costante della missione; “conservare la fede” esprime la custodia di un dono ricevuto, non come possesso statico, ma come tesoro che cresce nel dono di sé. Sebbene stanco e affaticato, Paolo si dice fiero di aver conservato il dono della fede che lo ha guidato e sostenuto in tutta la missione. Per questo ringrazia il Signore che in ogni pericolo ha manifestato la sua forza liberandolo da chi lo voleva morto. Questa è la forza pasquale della fede cristiana: la consapevolezza che anche nel fallimento umano Dio porta avanti il suo disegno. Il termine “corona” (stéphanos) richiama la vittoria dell’atleta o il riconoscimento del martire. Non è premio di merito, ma dono di fedeltà: Dio stesso incorona la sua grazia operante nell’uomo. Paolo non rivendica un credito, ma attende la pienezza di una promessa. La giustizia qui non è quella retributiva ma salvifica, che consiste nel riconoscimento del credente da parte del suo Signore. L’ora finale non la decide l’uomo ma Dio. Il martirio non è l’atto finale della missione, ma quello iniziale di una vita nuova perché il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. La fecondità della Chiesa è per Paolo la corona della vittoria che sugella l’opera di Dio.
Dunque, in questo testamento spirituale, Paolo non si esalta ma si offre come esempio. Timoteo, giovane pastore alle prese con timori e opposizioni, riceve un duplice invito: custodire la fede e non temere la fatica. L’apostolo mostra che la missione non si misura dai successi ma dalla fedeltà. Il pastore è chiamato a essere come lui: offerta quotidiana, voce che annuncia anche nelle catene, servo che persevera nell’amore fino al compimento.
La fede perseverante di Paolo diventa paradigma della vocazione pastorale: il ministero non è possesso, ma servizio; non dominio, ma dono di sé. La forza del pastore non sta nell’efficienza, ma nella fiducia che il Signore è vicino, anche quando tutti si allontanano. Così, la sua vita diventa un’icona della speranza cristiana: un’esistenza che, versata come libagione, illumina il cammino di chi è chiamato a servire il Vangelo con cuore indiviso.
In questa pagina, la sapienza della croce si fonde con la sapienza pastorale: la vittoria non è fuggire dalla morte, ma trasformarla in offerta. È il paradosso cristiano della fecondità della debolezza: l’“agon” dell’apostolo diventa il seme del Vangelo che continua a fiorire nella vita di chi, come Timoteo, accetta di lottare la stessa buona battaglia.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 18,9-14
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo.
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
Contesto biblico
• Sir 35,15-22: sezione cultuale del Siracide che sposta il peso dal rito al cuore. Dio, giudice imparziale, è parziale solo nell’amore per l’oppresso: la sua giustizia si manifesta ascoltando chi non ha altro appoggio che Lui.
• 2Tm 4,6-8.16-18: testamento di Paolo in catene. La vita come libagione (spéndomai), la missione come agon e corsa, la speranza come corona (stéphanos).
• Lc 18,9-14: la parabola svela che la vera “giustizia” nasce non dal confronto con gli altri, ma dall’umile consegna di sé a Dio.
Lectio
Se ami non dire a Dio “dammi ciò che mi spetta” ma “dimmi ciò che hai nel cuore”
Domenica scorsa la parabola, che vedeva come protagonisti una vedova petulante nel chiedere giustizia e il giudice disonesto che l’esaudisce per non essere ulteriormente infastidito, offriva l’occasione di verificare i tempi, i modi e i contenuti della preghiera cristiana. Come può dirsi cristiano colui che non prega? La preghiera cristiana, tuttavia, non si riduce a formule, ma è sempre un’esperienza corale e comunionale, anche se fatta nella solitudine. Anzi, proprio quando si lotta con fatica per non soccombere sotto il peso delle prove che la vita ci riserva e sentiamo il vuoto dentro e fuori di noi, la preghiera ci “connette” con Dio e con i fratelli.
La pericope, tratta dal cap. 35 del Libro del Siracide, sembra confermare quello che Gesù ha detto del Padre suo mettendolo a confronto con il ragionamento del giudice disonesto. Dio è Padre di tutti ed è giudice giusto, non perché ragiona secondo la legge, davanti alla quale le persone si distinguono in giusti e peccatori, ma in quanto imparziale nell’offrire a tutti il dono della salvezza. Colui che fa sorgere il sole e che fa piovere sui cattivi e suoi buoni, offre suo Figlio per tutti, cattivi e buoni. Nell’ultima cena Gesù inaugura la nuova ed eterna alleanza sancita dal dono del suo corpo e dall’effusione del suo sangue per la remissione di tutti i peccati, i peccati di tutti e, finalmente, il perdono a tutti (i peccatori). In realtà, se davanti alla legge siamo tutti uguali perché tutti peccatori, parimenti lo siamo davanti a Dio perché tutti suoi figli.
Tuttavia, la conclusione che trae Gesù dalla parabola, in cui c’è un fariseo impettito che cerca di presentarsi come distinto dagli altri peccatori e un pubblicano che si rivolge umilmente a Dio chiedendogli di amarlo così com’è, mette l’accento sull’effetto della loro preghiera. Infatti, solo uno dei due torna a casa giustificato, cioè santificato.
La giustificazione non è né un premio per i perfetti, né un “colpo di spugna” sui peccati. Si tratta di un miracolo, cioè di un’opera che solo Dio può compiere, ma ad una condizione: la fede dell’uomo. Il miracolo consiste nella creazione, meglio diremmo, nella ri-creazione dell’uomo che docilmente si pone nelle mani di Dio perché Lui lo plasmi a Sua immagine e somiglianza.
L’apostolo Paolo, riprendendo l’insegnamento di Gesù contenuto in questa parabola, ripete che l’uomo non è reso giusto dalle opere della legge, ma dalla fede che permette a Dio di cambiare il suo cuore. Il fariseo della parabola è come Giobbe del quale si dice che offriva i sacrifici di espiazione anche per i suoi figli che, magari distratti da altre cose, avrebbero potuto urtare la sensibilità di Dio e peccare. Giobbe era (o presumeva di essere) talmente giusto da sostituirsi nelle pratiche penitenziali ai suoi figli, così come il fariseo digiuna anche per chi non lo fa e paga la tassa per i poveri anche per quei commercianti che non lo fanno.
Questo tipo di giustizia non è quella di Dio ed è molto precaria, tanto che, come racconta il libro di Giobbe, quando la fortuna gli volta le spalle, la fede (o presunta tale) entra in una profonda crisi.
Colui che nell’euforia prega (?) vantandosi e al tempo stesso distinguendosi dagli altri, povera massa dannata, veste un impermeabile che impedisce veramente alla grazia di Dio di penetrare nel cuore. Alla base c’è una mentalità per la quale si confonde la volontà di Dio con un cieco destino e la Sua grazia come fortuna o come merito proprio.
La postura, il gesto e le parole del pubblicano rivelano che il suo rapporto con Dio non è come quello che creditore nei confronti del debitore, fosse anche un operaio nei confronti del suo padrone. La preghiera del fariseo assomiglia a quelle liturgie tanto pompose quanto inutili perché sovraccariche di ritualità insignificanti e retoriche. Quella del pubblicano è una preghiera semplice ma che è come freccia che raggiunge la volta del cielo superando le nubi. Il fariseo si nasconde dietro i suoi meriti mentre il pubblicano si mette a nudo. Il fariseo vuole dimostrare quanto vale, il pubblicano si mostra a Dio per quello che è.
Gli occhi bassi indicano la consapevolezza della propria fragilità; il gesto di battere il petto richiama l’opera dell’agricoltore che solca il terreno con l’aratro prima di seminare e del carpentiere che rompe la pietra prima di poggiare sulla roccia le fondamenta della nuova costruzione. Battersi il petto significa sentire il dolore del peccato, la sofferenza della distanza e della separazione da Dio e dai fratelli. Il pentimento non è un giudizio di colpevolezza ma è umile richiesta di aiuto a Dio, il Salvatore.
Il pubblicano, a differenza del fariseo, nella preghiera si fa povero, cioè crea spazio nel suo cuore sgomberandolo sia dalla presunzione, che colpevolizza gli altri, sia dai sensi di colpa che lo inchioderebbero ai suoi peccati.
Il giusto non è colui che, come il fariseo, presentandosi con le “carte in regola” davanti a Dio, pensa di essere migliore e di raggiungere da solo il traguardo della vita eterna, magari anche compiacendosi che gli altri siano esclusi. L’uomo giusto non solamente prega, ma fa della sua vita una preghiera nella quale fare spazio per accogliere il dono di Dio dentro di sé e ospitare il fratello così com’è.
Le parole di Paolo a Timoteo sono la testimonianza di un uomo che ha fatto della preghiera il tempio nel quale lasciarsi trasformare dalla misericordia di Dio. Colui che per difendere la dottrina non esitava a perseguitare gli altri fratelli e sorelle, per grazia di Dio è diventato mite combattente della buona battaglia. Dopo l’incontro con Gesù, Paolo, e con lui tutti gli apostoli e ogni uomo, non ha smesso di peccare, ma nell’assiduo e umile ascolto della Parola di Dio e nella Eucaristia celebrata in comunione con i fratelli di fede, si è lasciato conformare a Gesù, fino al punto di diventarne sua immagine vera e fedele.
La preghiera di lode del fariseo è falsa perché il motivo della benedizione non è l’opera di Dio ma la propria esaltazione. La supplica del pubblicano è vera perché non si lamenta giudicando gli altri, ma invoca l’aiuto di Dio. La preghiera è dialogo tra innamorati in cui non ci si vanta di quello che l’uno fa all’altro, ma, accogliendo l’altro per quello che è, gli si dice quello che si vuole essere per lui. La preghiera più bella non può essere che questa: Amami come sono, perché possa amare come te.
Nucleo teologico-spirituale
• Dio ascolta il povero: la preghiera che “attraversa le nubi” è ostinazione fiduciosa, non capriccio. È liturgia del cuore che Dio gradisce più di ogni offerta.
• La giustizia che salva: la “corona” non remunera meriti, ma riconosce una relazione custodita nella prova.
• Lo stile del ministro: Paolo non esibisce risultati; mostra fedeltà. È modello per Timoteo: servizio come offerta quotidiana, annuncio anche nelle catene, mansuetudine nella solitudine.
3 chiavi di lettura
- Imparzialità divina e preferenza pratica: Dio non fa preferenze “contro il povero”; dunque la sua giustizia ha un vettore: rialzare chi è a terra.
- Tre perfetti paolini (2Tm 4,7): “ho combattuto – ho terminato – ho conservato” → maturità che non si misura in successi, ma in custodia della fede.
- Giustificazione evangelica (Lc 18): il pubblicano non si giustifica; si lascia giustificare.
Meditatio
Questuanti di misericordia
«Due uomini salirono al tempio a pregare» questa scena non era infrequente come non lo era quella della parabola precedente in cui una povera vedova ottiene con la sua insistente richiesta la giustizia che le spettava ma che il giudice tardava a concedere. Quel racconto spiegava la necessità di pregare sempre, senza scoraggiarsi, perché Dio interviene a favore dei poveri. La nostra parabola, sulla scia della precedente, vuole sottolineare che Dio opera la giustizia rendendo giusta la persona che prega.
Solo in apparenza ci sono due uomini che pregano, ma in realtà è solo uno, quello che torna a casa giustificato. Si tratta del pubblicano disprezzato dal fariseo e da lui accomunato alla schiera degli altri uomini adulteri, ladri, ingiusti.
La differenza tra i due uomini che salgono al tempio a pregare non consiste nei loro meriti o nelle loro colpe, ma nel loro modo di rapportarsi a Dio: come creditore della benevolenza di Dio, il primo, come debitore della Sua misericordia, il secondo. Il fariseo, stando ritto con il petto in fuori, si rivolge a Dio alla stessa stregua di chi si mette davanti allo specchio vantandosi orgogliosamente delle proprie opere buone. L’uomo, presuntamente religioso, non si accontenta di esaltare sé stesso ma, per apparire il migliore, si paragona al pubblicano e lo disprezza credendo di uscire vincitore dal confronto. In realtà ritorna a casa sconfitto perché Dio non guarda l’apparenza ma il cuore. Il Signore gradisce la preghiera del pubblicano perché nel suo cuore, al contrario di quello del fariseo, c’è spazio per Lui.
Il disprezzo, che il fariseo ha nei confronti del fratello, smaschera il peccato di orgoglio il cui cattivo odore impregna la sua preghiera di ringraziamento e l’elenco delle buone opere. Così facendo egli, confessando implicitamente il suo peccato, invece di aprirsi al perdono, si scherma impedendo alla grazia di Dio di guarirlo. L’unico peccato imperdonabile è il rifiuto del perdono. Il presuntuoso che si presenta innanzi a Dio come il vanitoso davanti allo specchio oppone un netto diniego all’azione di Dio. Diretta conseguenza del narcisismo, anche quello di stampo religioso, è il disprezzo degli altri. Il fariseo della parabola prega tra sé compiacendosi e congratulandosi con sé stesso per quello che non è e per quello che fa. Per l’uomo fintamente pio esiste solo il proprio io. La relazione è praticamente inesistente, chiuso, com’è, nella sua autoreferenzialità. La chiusura in sé stessi esprime la volontà decisa di non cambiare e non lasciarsi cambiare.
Al contrario il pubblicano, consapevole dei suoi peccati, alimenta la speranza del perdono con la preghiera umile e fiduciosa. Il pentimento non è solo riconoscimento delle proprie mancanze, ma soprattutto la speranza del dono di Dio che rende puri e giusti. Il pubblicano insegna che davanti a Dio bisogna spogliarsi di ogni merito per farsi rivestire da Lui di santità e giustizia. Davanti all’altare possiamo presentarci solo a mani vuote perché Dio le possa riempire di opere buone nei confronti dei nostri fratelli. Del pubblicano non sappiamo nulla se non ciò che ci accomuna, ovvero il fatto di essere peccatori. La sua preghiera umile ci offre un esempio di stile di vita. Davanti a Dio non è necessario fare l’elenco né dei meriti né delle colpe, ma bisogna starci come ci si espone ai raggi del sole per goderne i benefici. La vita si gioca sull’umiltà di spogliarsi della vergogna e lasciarsi amare!
La preghiera non può essere una forma di auto esaltazione ma, come insegna il pubblicano che non confida in sé stesso ma esclusivamente nella misericordia di Dio, consiste nel riconoscere la propria piccolezza e, al contempo, la grandezza di Dio. Chiedere è un atto di umiltà, a maggior ragione quando, mediante la supplica imploriamo il perdono. Sebbene peccatore, cosciente di essere indegno di stare alla presenza di Dio, il pubblicano non si nasconde dietro l’alibi della propria impurità ma con fede si rivolge a Dio come ad un padre comprensivo e benevolo, ma anche giusto ed esigente. Il fariseo parla tra sé esprimendo in un monologo il suo autocompiacimento mentre il pubblicano lascia parlare il cuore intessendo con Dio un dialogo d’amore.
Ciò che fa la differenza tra le due persone davanti a Dio è il fatto che il fariseo si nasconde dietro l’apparenza della giustizia, mentre il pubblicano si mette a nudo per ricevere la giustizia. Gesù aveva ricordato che Dio fa prontamente giustizia ai poveri che gridano a lui. Solo il grido del povero intenerisce il cuore di Dio da cui sgorga copiosa la sua misericordia; al contrario le grida dei presuntuosi, che disprezzano gli altri, gli provocano disgusto.
Il fariseo, pieno di sé s’incammina sulla via che lo condurrà agli inferi con tutte le sue pie pratiche, mentre il pubblicano e accolto nell’abbraccio paterno perché si è fatto povero e, perciò stesso, accogliente del dono di Dio. La preghiera non può essere finalizzata a ottenere un riconoscimento ma ad accogliere con speranza e fiducia ciò che cambia interiormente. Il fariseo punta sull’apparenza, il pubblicano sull’essenza.
Domande guida
- In che cosa, oggi, la mia preghiera “attraversa le nubi”? Dove, invece, resta intrappolata nell’aria della mia autosufficienza?
- Qual è “la buona battaglia” concreta che il Signore mi chiede di combattere adesso (non ieri, non domani)?
- Dove sento la tentazione del fariseo: autogiustificazione, confronto, disprezzo sottile? Quale gesto pratico di umiltà posso scegliere?
- Chi sono, nel mio territorio, gli “orfani e vedove” di oggi (solitudini, povertà educative, malati invisibili)? Come la comunità ascolta il loro grido?
- Che cosa significa per me “conservare la fede” nel tempo della stanchezza pastorale? Quale piccola disciplina (Parola, Eucaristia, visita ai poveri) devo custodire con tenacia?
- Quale “corona” sto inseguendo senza accorgermene (considerazione, numeri, efficienza)? Come riorientarla verso la “corona di giustizia”?
Oratio
Signore Gesù, cuore mite e umile,
non vengo a chiederti ciò che “mi spetta”,
ma ad ascoltare ciò che hai nel cuore per me.
Spogliami dell’orgoglio che mi difende da Te e dagli altri,
spezza le mie pretese benedette da me stesso,
ridonami la verità semplice del pubblicano:
“Abbi pietà di me, peccatore”.
Rendimi questuante di misericordia:
con le mani vuote, il petto aperto,
la fiducia ostinata di chi bussa e attende.
Fa’ che la mia preghiera attraversi le nubi
non per comprare il tuo favore,
ma per lasciare a Te lo spazio di purificare il mio cuore.
Dì tu, Signore, ciò che porti nel cuore:
parole che arano la terra dura,
luce che scende nelle stanze buie,
olio e vino sulle ferite taciute.
Che la tua volontà mi raggiunga dove resisto,
e mi rialzi dove sono caduto.
Liberami dal confronto che disprezza,
dalla lode che odora di vanità,
dalla legge usata come scudo.
Donami la fede che conserva,
la corsa che non si vanta,
l’offerta che si versa in silenzio.
Fammi vicino agli orfani di speranza,
alle vedove di affetto, ai poveri di ascolto:
che la loro voce diventi la mia preghiera,
e la mia casa ritorni piena di fratelli.
Sia la mia vita una liturgia del quotidiano,
il mio ministero un servizio senza bilance,
la mia gioia la tua misericordia condivisa.
Allora, tornato a casa,
non sarò giustificato dalle mie opere,
ma dalla tua grazia che mi avrà colmato il cuore
di pace e consolazione.
A Te, Giudice giusto e Padre dei poveri,
la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
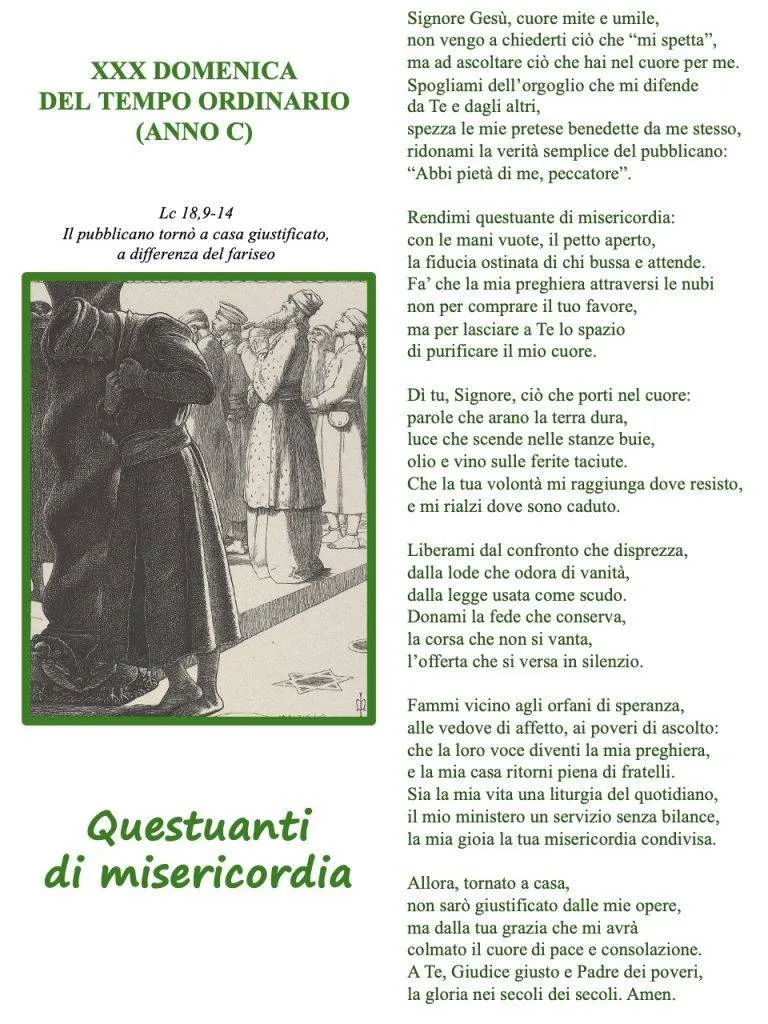

Commenti recenti